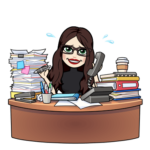"Adolescence": uno specchio inquietante sulla fragilità digitale dei nostri figli
#life
La serie Netflix Adolescence non è solo un crime drama ben scritto: è una rappresentazione cruda e disturbante di quello che sta accadendo, oggi, nel mondo (digitale) di molti ragazzi. E quando parliamo di ragazzi, dovremmo forse dire bambini, perché l’età in cui tutto comincia si è drammaticamente abbassata.
Al centro della serie c’è Jamie Miller, un tredicenne accusato dell’omicidio di una compagna di scuola. Ma ciò che la fiction riesce a restituire – e che fa più male – è il contesto in cui Jamie è cresciuto: un ecosistema digitale tossico, fatto di influencer della cosiddetta manosfera, contenuti misogini, gruppi che esaltano l’iper-mascolinità tossica, in cui mostrarsi vulnerabili è un peccato capitale e la donna viene vista come nemica o oggetto.
Una realtà che fa più paura della finzione.
Negli ultimi mesi, la cronaca italiana ha riportato fatti tragici che sembrano specchiarsi in questa narrazione.
Andrea Prospero, 19 anni, si era trasferito a Perugia per studiare informatica. Il 24 gennaio 2025 è stato trovato senza vita nel suo appartamento nel centro storico, dopo aver ingerito un mix letale di oppiacei acquistati illegalmente online, utilizzando ricette false.
Le indagini hanno rivelato una dinamica ancora più inquietante: un diciottenne romano, conosciuto solo virtualmente, avrebbe istigato Andrea al suicidio, fornendogli istruzioni dettagliate sull’assunzione dei farmaci e incitandolo a portare a termine il gesto. Non solo: una volta saputo che Andrea li aveva assunti, invece di avvisare i soccorsi, avrebbe cercato di cancellare le prove e le tracce digitali. Il ragazzo attualmente si trova agli arresti domiciliari.
Antonio De Marco, 21 anni, studente di scienze infermieristiche, il 21 settembre 2020, a Lecce, ha ucciso brutalmente Daniele De Santis, 33 anni, arbitro di calcio, e la sua fidanzata Eleonora Manta, 30 anni. L’autore del duplice omicidio è e ex coinquilino della coppia.
De Marco ha confessato di aver pianificato l’omicidio per settimane, spinto da un sentimento di invidia e rabbia nei confronti della felicità della coppia. Le vittime sono state colpite con decine di coltellate: 38 a Daniele e 41 a Eleonora. La Corte d’Assise di Lecce ha condannato De Marco all’ergastolo, riconoscendo la premeditazione e la crudeltà del gesto.
Questo caso evidenzia come l’incapacità di gestire emozioni negative e l’isolamento sociale possano sfociare in atti di violenza estrema. La mancanza di empatia e l’assenza di strumenti per affrontare il disagio emotivo rappresentano un rischio concreto, soprattutto tra i giovani.


Non possiamo più aspettare.
L’idea che certi temi – come l’educazione affettiva, il rispetto dell’altro, la gestione delle emozioni e l’uso consapevole della tecnologia – possano essere affrontati solo durante l’adolescenza è ormai superata. Aspettare che i ragazzi arrivino alle scuole superiori potrebbe essere tardi.
I comportamenti, le convinzioni, i modelli di riferimento iniziano a formarsi spesso già nella preadolescenza. È in quella fase che i ragazzi cominciano a cercare appartenenza, a definirsi attraverso il gruppo, a sviluppare una propria identità anche digitale. Se lasciati soli in questo percorso, senza strumenti culturali ed emotivi adeguati, diventano terreno fertile per messaggi violenti, discriminatori o distorti che circolano online.
La vera prevenzione comincia prima, con percorsi educativi strutturati, integrati nei curricula scolastici, capaci di parlare ai ragazzi con il linguaggio giusto, nel momento giusto. Ed è lì, nelle aule delle scuole medie, che possiamo ancora intercettare i segnali, aprire dialoghi, correggere rotte.
Presenza, consapevolezza, responsabilità
Di fronte a questo scenario, non possiamo limitarci a indignarci o a sperare che “passi con l’età”. Come adulti (genitori, educatori, professionisti) abbiamo il dovere di agire, con lucidità e coerenza.
Portare l’educazione digitale e affettiva nelle scuole: non come “progetto occasionale”, ma come parte stabile e continuativa del percorso formativo. Serve un impegno istituzionale, multidisciplinare, con il coinvolgimento di psicologi, pedagogisti ed esperti in comunicazione digitale.
- Il progetto “GENER-AZIONE 5” promosso da ACRA nelle scuole secondarie di primo grado mira a prevenire la violenza di genere attraverso laboratori interattivi e percorsi di sensibilizzazione.
Accompagnare, non solo controllare: i genitori devono essere formati per affiancare i figli nel loro percorso online. Non basta vietare o limitare: serve comprendere, dialogare, offrire strumenti per interpretare ciò che vivono in rete.
- La guida sull’educazione digitale di Save the Children fornisce consigli pratici per genitori e adulti di riferimento, aiutandoli a supportare i ragazzi nella navigazione online in modo sicuro e consapevole.
Ridefinire i modelli di riferimento maschili: promuoviamo figure in cui la forza sia anche vulnerabilità, la leadership sia anche cura, il rispetto non sia debolezza. Contrastare l’iper-mascolinità non significa negare l’identità maschile, ma liberarla da stereotipi pericolosi.
- Il progetto “EduForIst”, commissionato e finanziato dal Ministro della Salute e coordinato dall’Università di Pisa, si propone, tra l’altro, di affrontare gli stereotipi di genere nelle scuole attraverso attività educative che promuovono l’uguaglianza e il rispetto reciproco.
Intervenire con gli strumenti del diritto: la rete non può essere un luogo di impunità. I contenuti che istigano all’odio, alla violenza, alla discriminazione vanno segnalati e, se necessario, perseguiti. Anche qui, prevenzione e repressione devono camminare insieme.
- La Piattaforma ELISA offre formazione e risorse per docenti e studenti, focalizzandosi sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, fornendo strumenti legali e educativi per affrontare queste problematiche.
Educare, proteggere e responsabilizzare sono azioni che richiedono tempo, visione e costanza.
Ma soprattutto, richiedono presenza.
Perché la solitudine – fisica, affettiva o digitale – è spesso l’anticamera delle tragedie che non vorremmo più raccontare.